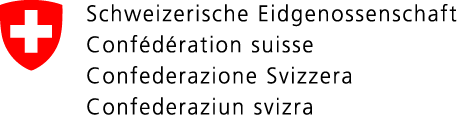Impronta dell’impatto ambientale complessivo
L’indicatore mostra l’impatto complessivo in Svizzera e all’estero in tutti i settori ambientali collegato alla domanda finale svizzera. Così, vengono conteggiate le materie prime e l’energia necessarie per la produzione di beni di consumo nonché gli insediamenti, i mezzi di trasporto e l’utilizzo di superfici e acqua per la produzione di mangime e generi alimentari. Mentre gli effetti dello sfruttamento eccessivo delle risorse sul sistema economico e la qualità di vita in Svizzera dovrebbero essere visibili solo sul medio-lungo termine, altri Paesi risentono già oggi di tali effetti a causa del disboscamento delle foreste, dei cambiamenti climatici o della scarsità di acqua.
 scadente
scadente
 positivo
positivo
Tra il 2000 e il 2022 l’impronta dell’impatto ambientale complessivo pro capite (con oscillazioni annuali) è diminuito del 33 per cento, passando da circa 36 milioni a 24 milioni di punti di impatto ambientale (PIA). Tuttavia, l’aumento della popolazione in questo periodo, fa sì che la diminuzione assoluta sia inferiore (18 %). Poiché molti prodotti sono importati, l’impatto ambientale si verifica soprattutto all’estero. Nel 2022 piu di due terzi dell’impatto ambientale si è verificato all’interno dei confini nazionali.
Poiché la produzione e il consumo di beni e servizi sono legati all’impatto ambientale, ci si potrebbe aspettare che l’impatto ambientale complessivo aumenti in modo analogo alla domanda finale. Non è questo il caso: mentre tra il 2000 e il 2021 la domanda finale svizzera è aumentata del 28 per cento, l’impatto ambientale globale è addirittura diminuito. Si è quindi verificata un disaccoppiamento tra il benessere e l’impatto ambientale globale. In altre parole, la cosiddetta efficienza ambientale complessiva è migliorata.
L’attuale tendenza va ricondotta per esempio ai successi ottenuti in Svizzera nella protezione dell’aria e dello strato di ozono. In tale contesto, le disposizioni legali e lo sviluppo tecnologico hanno avuto un ruolo centrale. Anche le quote più elevate di beni e servizi rispettosi dell’ambiente possono avervi contribuito.
Tuttavia, l’attuale impatto ambientale complessivo supera di quasi tre volte i valori soglia di un uso sostenibile delle risorse. I valori limite di detto calcolo si orientano ai limiti di resistenza del pianeta, agli obiettivi della politica ambientale della Svizzera e alla stima dei consumi globali.
La diminuzione registrata finora dell’impatto ambientale complessivo non consente di raggiungere entro il 2030 il valore soglia e dunque l’obiettivo dell’Agenda 2030 di un uso sostenibile delle risorse. Inoltre, i progressi fatti non coprono tutti i settori ambientali. Pertanto, lo stato è giudicato scadente.
L’indicatore dei punti di impatto ambientale si basa sugli obiettivi di politica ambientale svizzera. Non è quindi possibile un confronto internazionale. L’approccio è stato incluso nel dialogo scientifico in Paesi come la Germania e il Giappone.
Metodo di aggregazione di impatti ambientali di diversa natura: per poter rilevare e valutare l’impatto ambientale complessivo di tutti gli effetti ambientali, come ad esempio le emissioni nell’aria e nelle acque, i metalli pesanti nel suolo, il consumo di materie prime ecc., sono necessari metodi che possono riassumere in una cifra questi impatti. Nel presente esempio è stato utilizzato il metodo della scarsità ecologica, detto anche metodo PIA. Questo metodo esprime tutti gli effetti ambientali in punti di impatto ambientale (PIA). Con il metodo PIA, i diversi effetti ambientali vengono ponderati in base alla differenza tra la situazione ambientale attuale (emissioni e domanda di risorse) e gli obiettivi ambientali di uno Stato o di una regione mediante i cosiddetti fattori ecologici («distance-to-target approach»). In Svizzera, il metodo PIA si orienta agli obiettivi ambientali svizzeri e internazionali, legittimati politicamente, i quali si basano su conoscenze scientifiche. Maggiore è la distanza ad esempio di un valore di emissione attuale di un inquinante dal valore obiettivo, maggiore sarà il peso accordato al corrispondente effetto ambientale nel bilancio globale. L’entità effettiva dell’impatto ambientale dipende tuttavia in via definitiva dalla quantità di inquinante emessa. La quantità emessa viene in seguito moltiplicata per il fattore ecologico dell’emissione.
Metodo per la prospettiva dell’impronta ecologica: per modellizzare l’impatto ambientale provocato dalla domanda finale, viene presa in considerazione l’intera catena del valore aggiunto di tutti i beni e servizi consumati, ossia i costi di estrazione, la produzione, il trasporto ecc. fino all’utilizzo e allo smaltimento. Oltre alle risorse consumate e alle emissioni generate in Svizzera, si tiene conto anche della pressione sull’ambiente generata all’estero. L’impatto ambientale dei beni esportati viene dedotto, in quanto non fa parte dei consumi interni. Questi sono i limiti del sistema della cosiddetta prospettiva dell’impronta ecologica o dei consumi.
I calcoli che ne costituiscono la base provengono dalla pubblicazione Le impronte ambientali della Svizzera: sviluppo tra il 2000 e il 2018 (EBP/Treeze 2022) e dal successivo aggiornamento.
Confronto con l’«impronta ecologica»: L’indicatore è simile all’«impronta ecologica» del Global Footprint Network, ma i due non vanno confusi. Quello del Global Footprint Network riassume in una cifra dalla prospettiva dei consumi l’utilizzazione diretta del suolo, la cattura di pesci e le superfici boschive (teoricamente) necessarie per compensare le emissioni fossili di CO2 necessarie. L’impronta ecologica non è un indicatore ambientale esauriente. Il consumo di acqua dolce e altre risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili come pure la perdita di biodiversità o l’impatto ambientale causato da inquinanti atmosferici, metalli pesanti, azoto e inquinanti organici persistenti non sono considerati. Il suo valore aggiunto risiede nella comunicazione chiara e nel fatto che è ampiamente conosciuto. Secondo le stime, l’impronta ecologica della Svizzera supera di quasi tre volte la capacità biologica globale. Nonostante le grandi differenze metodologiche, la necessità d’intervento che ne risulta è dello stesso ordine di grandezza di quella del metodo PIA.
| Evoluzione auspicata | Valore iniziale | Valore finale | Variazione in % | Evoluzione osservata | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Calo | Media 2000-2002 | Media 2020-2022 | -31.32% | Calo | positivo |
| Base: Totale impronte pro capite | |||||
Ulteriori informazioni