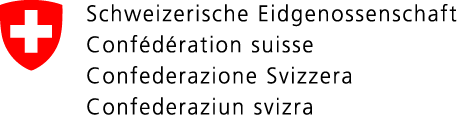Bilancio dei gas serra da uso del territorio
Nel settore dell’Uso del territorio vengono rilevati i flussi di gas serra rilasciati o assorbiti dall’uso del territorio o che derivano da un cambiamento dell’uso del territorio (ad es. costruzione di case su terreni una volta coltivi). A differenza degli altri settori che producono esclusivamente emissioni, la quantità di carbonio contenuta nella vegetazione e nel suolo può aumentare o diminuire. In questo modo, il diossido di carbonio (CO2) viene sottratto o immesso nell'atmosfera.
 medio
medio
 nessuna valutazione possibile
nessuna valutazione possibile
Le foreste occupano il primo posto nel bilancio svizzero dei gas serra da uso del territorio. Ad eccezione di un solo anno (2000), la gestione forestale ha sempre contribuito a incrementare la riserva di carbonio totale negli alberi, nel legno morto, nella lettiera e nel suolo boschivo (il cosiddetto pozzo di carbonio dei boschi). Gli utilizzi forzati dopo tempeste violente (Vivian nel febbraio 1990, Lothar nel dicembre 1999) e l’aumento del legno raccolto in singoli anni (ad es. 2006 e 2007) sono chiaramente riconoscibili. I dati dell’Inventario forestale nazionale mostrano che dal 1990 la foresta svizzera tende ad assorbire e immagazzinare ogni anno meno CO2. Non è chiaro quali saranno gli effetti in Svizzera dell’aumento delle estati calde e secche dell’ultimo decennio, che ha causato gravi danni alle foreste in molti paesi europei. Di fronte ai cambiamenti climatici già osservati e a quelli che stanno emergendo, le foreste sensibili devono essere adattate alle future condizioni ambientali attraverso una selvicoltura adattiva e naturale. Le misure necessarie a tal fine potrebbero ridurre temporaneamente la capacità di assorbimento del carbonio della foresta, ma a lungo termine ridurranno il rischio di danni su larga scala causati da disturbi naturali.
Una gestione forestale adeguata nell’ottica della politica climatica sarà possibile con un cosiddetto utilizzo a cascata dell’incremento legnoso, impiegato in un primo tempo in prodotti di legno di qualità e di lunga durata e solo in un secondo tempo come fonte di energia. In quasi tutti gli anni dal 1990 la quantità di legno utilizzata in nuovi prodotti (ad es. legno da costruzione o per la fabbricazione di mobili) ha superato quella rilasciato (come CO2) durante lo smaltimento e/o la combustione di prodotti in legno dismessi. Tuttavia, l’effetto annuo di pozzo di assorbimento dei prodotti legnosi ha mostrato una tendenza al ribasso negli ultimi decenni.
L’utilizzo agricolo dei terreni coltivi e prati influenza il tenore di carbonio nei suoli. Per esempio, l’aratura favorisce la decomposizione dell’humus, mentre lo spandimento di concimi aziendali o i residui di raccolto lasciati nei campi aumentano il tenore di carbonio. Oltre alla modalità di gestione, sono soprattutto le colture e le condizioni meteorologiche che influiscono sulle oscillazioni annuali. Un caso a parte è rappresentato dalle paludi prosciugate: questi suoli fertili rilasciano quantità elevate di gas serra (CO2 e N2O) in caso di utilizzo agricolo intensivo.
Oggi le zone umide costituiscono solo una piccola parte della superficie del Paese. Dal momento che quasi tutte le torbiere sono danneggiate dalle conseguenze di precedenti utilizzi (soprattutto drenaggi), la formazione di torba si è arrestata e in molti luoghi i pozzi di assorbimento si sono trasformati in fonti di gas serra.
Dal 1990 lo sviluppo di nuovi insediamenti ha prodotto quantità relativamente contenute di emissioni. Ciò avviene soprattutto se per i lavori di costruzione devono essere abbattuti degli alberi. Al contrario, il crescente inverdimento delle superfici impermeabilizzate negli ultimi decenni ha contribuito a contenere le emissioni nette nelle aree urbane.
Le altre superfici come le rocce, le falde detritiche e i margini proglaciali hanno scarsa vegetazione e suoli poco o per nulla sviluppati. Il loro ruolo nel bilancio dei gas serra è trascurabile.
Ad eccezione degli anni 2000, 2015, 2018 e 2023 l’uso del territorio in Svizzera ha fatto sì che vegetazione e suoli abbiano assorbito più CO2 dall’atmosfera di quanto ne abbiano rilasciati. Le emissioni nette annuali di gas serra della Svizzera sono diminuite grazie a questo servizio ecosistemico. In particolare, l’uso non sostenibile delle ex torbiere e il consumo di territorio per aree insediative e di trasporto continuano a rilasciare gas serra. Per questo motivo, la situazione non è pienamente soddisfacente. Molti fattori, come la politica forestale e agricola, la pianificazione territoriale, l’attività edilizia e gli eventi meteorologici estremi influenzano il bilancio dei gas serra del settore dell’uso del territorio. Non sono stati ancora definiti criteri per valutare l’andamento dell’indicatore.
- Indicatori correlati
- Emissioni di gas serra
- Treibhausgasemissionen nach Gasen
- Treibhausgasemissionen nach Sektoren
Il bilancio dei gas serra da uso del territorio può essere raffrontato ai dati di altri Paesi, in quanto è calcolato in conformità alle linee direttive dell’IPCC.
I dati provengono dall’inventario dei gas serra della Svizzera (settore «Land Use, Land-Use Change and Forestry»), elaborato ogni anno dall’UFAM secondo le disposizioni della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. I metodi sono conformi a quelli indicati nelle direttive dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
I flussi di gas serra vengono rilevati per sei categorie di uso del territorio: foreste, terreni coltivi, prati, zone umide, insediamenti e altre superfici. Inoltre, viene considerato il carbonio contenuto nei prodotti legnosi svizzeri. In questo settore il CO2 è di gran lunga il principale gas serra. Alle emissioni contribuiscono in piccola parte anche il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O) prodotto da incendi, perdita di humus, bacini di ritenuta e suoli torbosi prosciugati. Le emissioni di CH4 e di N2O, convertite in CO2 equivalenti, sono cumulate con quelle di CO2.
Ulteriori informazioni