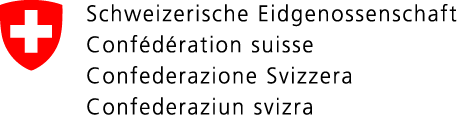Il Consiglio federale fissa un obiettivo ambizioso per la Svizzera: dimezzare le perdite alimentari evitabili entro il 2030. A questo scopo ha adottato un piano d’azione per affrontare il problema in modo globale e ha stipulato un accordo con il settore alimentare per coinvolgere il maggior numero possibile di attori, dalla produzione alla vendita.
Testo: Roland Fischer

È un ricordo d’infanzia molto vivo: per colazione mio padre mangiava sempre gli ultimi avanzi di pane raffermo inzuppati nel latte. A noi bambini toccava il pane fresco. Ricordo anche la nostra silenziosa incomprensione: perché non si tagliava una fetta di pane fresco anche lui? Faceva in modo che non si buttasse via nulla, nemmeno una briciola, senza alcun intento moralistico. Forse è anche per questo che il ricordo ha plasmato le mie abitudini di consumo solo a metà. Certo, mi sforzo di riutilizzare in qualche modo il pane raffermo, ad esempio preparando alcune ricette che arrivano dal passato, come il pane fritto, dolce o salato, il pane alle mele o le fette di pane al forno con formaggio. Troppo spesso, però, una buona parte del pane che compro finisce nella spazzatura. Pare sia un’abitudine diffusa: in Svizzera circa 2,8 milioni di tonnellate di cibo all’anno non vengono consumate bensì gettate via. Se lo si considera attraverso l’intera catena del valore, ciò equivale a circa 330 chilogrammi di rifiuti alimentari evitabili per persona ogni anno, una cifra impressionante.
Che cos’è lo spreco alimentare?
Quando si leggono le statistiche, proprio alla voce pane si stenta a credere ai propri occhi: secondo un rapporto redatto dal Gruppo per la progettazione di sistemi ecologici del Politecnico federale di Zurigo per conto dell’UFAM, mangiamo solo la metà dei cereali coltivati per il nostro pane, mentre il resto, come genere alimentare, prima o poi va perso lungo la catena del riciclo. Poiché le cose non sono così chiare dappertutto come a casa mia, alla fine della catena, quando lascio che il pane diventi vecchio e lo elimino, volente o nolente. Lo spreco alimentare non riguarda solo il cibo preparato che viene gettato via invece di mangiarlo, in quanto le statistiche includono tutte le perdite alimentari, dal campo al piatto.
Ad esempio, per quel che riguarda lo spreco alimentare di pane, succede qualcosa di determinante già subito dopo il raccolto. Si producono farine di vario tipo, alcune delle quali contengono una grossa parte del chicco intero, altre solo la parte interna del chicco, da cui derivano sottoprodotti della macinazione. Questi sottoprodotti, come la crusca, non finiscono tra i rifiuti in Svizzera bensì diventano spesso mangime per animali. Ciò significa che maggiore è la quota di mercato di pane con un’alta percentuale di farina integrale, minore è la quantità di sottoprodotti della macinazione e dunque di perdite alimentari. Un altro esempio di sottoprodotti della macinazione che vengono sistematicamente eliminati dai mulini industriali e che spesso non vengono mangiati dall’uomo sono i semi germogliati, i quali hanno un elevato valore nutritivo-fisiologico e le cui possibilità di utilizzo come alimento sono molteplici.
Quale sia il metodo di riciclo più ecologico per le perdite alimentari come la crusca è una delle questioni affrontate da un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dell’industria della trasformazione e Josef Känzig, capo della sezione Consumo e prodotti dell’UFAM. «Calcoliamo le perdite e il loro riciclo non solo in tonnellate, ma anche in termini di impatto ambientale», spiega Känzig. E un pezzo di carne che va a male in frigorifero pesa molto di più di una carota lasciata nel campo. Sono proprio queste ripercussioni sull’ambiente a rendere così urgente la questione dello spreco alimentare. È opportuno fare qualcosa a tale riguardo non solo dal punto di vista economico, ma anche in relazione al cambiamento climatico nonché al consumo di acqua, suolo ed energia.
Piano d’azione integrato e accordo intersettoriale
Anche Claudio Beretta, che all’interno del gruppo per le tecnologie alimentari della ZHAW studia lo spreco alimentare, considera la prevenzione di questo fenomeno una priorità assoluta. «Si tratta praticamente dell’obiettivo più a portata di mano nell’ambito della protezione dell’ambiente, poiché non grava sul portafoglio né limita la qualità della vita».
Quindi, diamoci da fare! Anche il Consiglio federale si è espresso in tal senso, adottando un piano d’azione contro lo spreco alimentare nell’aprile 2022. Insieme agli attori del settore alimentare, intende dimezzare in Svizzera rispetto al 2017 la quantità di perdite alimentari evitabili entro il 2030, in linea con l’obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3 dell’ONU. Raggiungendo questo obiettivo, si potrebbero ridurre l’impatto ambientale e le emissioni di gas serra dovuti all’alimentazione del 10-15 per cento. «È possibile ottenere questo risultato solo con uno sforzo congiunto», sostiene Beretta, poiché il sistema di mercato è molto complesso.
Beretta valuta quindi il relativo accordo intersettoriale molto positivamente, perché significa avere a bordo tanto i rappresentanti del commercio al dettaglio quanto molte grandi aziende di produzione e trasformazione. Riconosce «una forte motivazione a cambiare finalmente qualcosa», il che non sorprende più di tanto, considerato che evitare lo spreco alimentare significa non solo proteggere il clima, ma nella maggior parte dei casi anche alleggerire l’onere di bilancio. Uno studio inglese ha recentemente concluso che ogni franco investito per ridurre lo spreco alimentare si ripaga 14 volte.

© Raisa Durandi/Lunax/BAFU
Woher kommt Ihr Interesse am Kampf gegen Lebensmittelverschwendung?
Claudio Beretta: Ich interessiere mich für Umweltwissenschaften, seit ich mich für eine Ausbildung entscheiden musste. Ich komme aus einer Arztfamilie und hatte schon immer den Gedanken, die Menschen und den Planeten zu heilen. Das Studium der Umweltwissenschaften bot mir die inspirierende Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen den Aktivitäten des Menschen und dessen Auswirkungen auf die Umwelt besser zu verstehen. Was die Lebensmittelverschwendung betrifft: Sie ist ein Bereich mit enormem Handlungspotenzial, da ein Drittel aller importierten und in der Schweiz produzierten Lebensmittel nicht konsumiert wird.
Worauf konzentrieren Sie sich in Ihrer Forschung am meisten?
Food Waste ist ein grosses Problem, dennoch stammen die ersten Zahlen für die Schweiz erst aus dem Jahr 2012. Darum interessierte ich mich dafür, die Auswirkungen der Lebensmittelverschwendung auf die Umwelt zu quantifizieren. Dann fand ich heraus, dass João Almeida an der Universität Basel an demselben Thema arbeitete. Wir beschlossen zusammenzuarbeiten und die Plattform Foodwaste.ch zu gründen.
Was ist das Ziel der Plattform?
Mit Foodwaste.ch verbinden wir Forschung und Gesellschaft. Über den Verein organisieren wir Sensibilisierungsaktionen für die Bevölkerung. So kochen wir bei unseren Banketten etwa mit Gemüse, das den Normen nicht entspricht und normalerweise weggeworfen würde. Während des Essens tauschen wir uns mit den Anwesenden aus. Wir achten sehr auf positive Kommunikation und inspirierende Ansätze. Etwa auch bei der «foodwaste challenge». Die Idee: Die Teilnehmenden fotografieren sich mit Lebensmitteln, die sie vor der Verschwendung gerettet und beispielsweise mit ins Büro genommen haben. Auf unserer Onlineplattform Foodwaste.ch bieten wir auch Inhalte und Tipps, wie man Verschwendung vermeiden kann, indem man seine Einkäufe besser organisiert und seine Lebensmittel besser aufbewahrt. Es ist wichtig, Verbraucherinnen und Verbraucher daran zu erinnern, dass sie wirklich etwas für einen besseren Umgang mit Konsumgütern tun können. Schliesslich fällt die Hälfte der Lebensmittelverschwendung in der Schweiz in den Haushalten und in der Gastronomie an.
Was lässt sich im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung sonst noch tun?
Ich denke, es muss noch viel getan werden, um das Verständnis von Haltbarkeitsdaten zu verbessern. Häufig geht vergessen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum eine reine Qualitätsgarantie ist und nichts mit Lebensmittelsicherheit zu tun hat. In einem Projekt der ZHAW, das vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in Auftrag gegeben wurde, entwickeln wir konkrete Empfehlungen, damit Geschäfte einwandfreie Lebensmittel noch für eine gewisse Zeit nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum verkaufen oder verschenken können oder leicht verderbliche Lebensmittel vor dem Verbrauchsdatum einfrieren.
Wie kann man Menschen dazu bringen, sich generell mehr um die Umwelt zu kümmern?
Die Fakten sprechen für sich, nun geht es darum, sie bekannt zu machen. Heute werden Milliarden Franken unnötig in die Produktion von Lebensmitteln investiert, die dann weggeworfen werden. Diese Absurdität liesse sich vermeiden. Dabei ist auch wichtig, sich bewusst zu sein, dass mehr als ein Drittel aller Lebensmittel aus dem Ausland importiert wird – und zwar häufig aus Ländern, in denen die Bevölkerung nicht genug zu essen hat. Verschwendung zu vermeiden, hilft also auch dabei, ein besseres globales Gleichgewicht zu gewährleisten. Lebensmittelverschwendung ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch eine wirtschaftliche und ethische Frage.
Commercio al dettaglio: la grande leva
Torniamo a parlare di pane. Si presta infatti come buon esempio anche da un altro punto di vista per far comprendere la complessità del problema dello spreco alimentare in alcuni casi. Se si osservano più da vicino le statistiche, sembra quasi che il commercio al dettaglio sia esente dalla questione: qui solo 13 000 tonnellate di pane e prodotti da forno finiscono ogni anno nella spazzatura, pari a circa il due e mezzo per cento dell’impatto ambientale totale causato dalle perdite alimentari di questi generi alimentari. Nell’industria della trasformazione, nella ristorazione o nelle economie domestiche si registrano perdite decisamente più alte – addirittura, con 120 000 tonnellate di scarti di pane, le famiglie sono responsabili di oltre il 50 per cento dell’impatto ambientale totale. Significa dunque che i commercianti al dettaglio fanno tutto bene?
Non proprio, dice Beretta: «Bisogna fare attenzione a non interpretare male i numeri». Infatti, considerata la «struttura nel mercato», il commercio al dettaglio ha un ruolo determinante, che va ben oltre ciò che rimane sugli scaffali. Anche Känzig lo conferma: «Il commercio al dettaglio è un attore importante per la riduzione delle perdite alimentari perché ha una grande influenza, sia sui produttori sia sui consumatori». Quali prodotti vengono acquistati e quali sono considerati «invendibili»? In un certo qual modo il commercio al dettaglio regola il nostro modo di utilizzare gli alimenti. Può anche influenzare il comportamento di acquisto: le promozioni di grandi quantità di prodotti rapidamente deperibili determinano una maggiore quantità di spreco alimentare.
Per limitare le perdite alimentari, il settore si è organizzato nella piattaforma «United Against Waste», che mira anch’essa a dimezzare gli sprechi entro il 2030, collegando fra loro le aziende del settore alimentare e fornendo loro informazioni e consulenza. La piattaforma conta circa 190 membri, tra cui Coop e Migros, due realtà che hanno un ruolo decisivo nel mercato alimentare svizzero. Attraverso il portavoce comune, IG Detailhandel Schweiz, il settore alimentare fa sapere di valutare positivamente l’impegno e il piano d’azione del Consiglio federale: «Non tutte le misure funzionano in ogni contesto, per cui sono necessari approcci sia congiunti che individuali».
Un piccolo passo avanti rispetto alle dimensioni standard
Cosa potrebbe significare nella pratica lo spiega Christian Sohm, direttore di Swisscofel, l’associazione svizzera per il commercio di frutta, verdura e patate. Per attirare la clientela, per molto tempo si è ritenuto che fosse meglio presentare in negozio prodotti omogenei, vale a dire mele, finocchi, cavoli: tutti dello stesso aspetto. «Ma un single acquista quantità molto diverse rispetto a un padre di famiglia con tre figli, per cui i cavolfiori dovrebbero essere di dimensioni completamente diverse». Insieme si stanno attualmente adeguando questi standard. Tuttavia non bisogna essere ingenui a questo proposito, dice Sohm: «Se una mela Gala non è abbastanza rossa, rimane lì».
Di conseguenza, nel piano d’azione si afferma che nel commercio al dettaglio si dovrebbe vendere un maggior numero di prodotti di seconda scelta o di dimensioni diverse e che anche i clienti devono essere sensibilizzati sulla questione degli standard rigorosi e delle relative ripercussioni». In questo contesto Sohm menziona la frutta e la verdura con marchio Ünique di Coop, sicuramente poco significativa in termini di volume, ma niente affatto trascurabile. È così che i consumatori possono comprendere. Anche IG Detailhandel incoraggia i suoi membri a offrire più prodotti sfusi o in confezioni più piccole, in modo che i clienti possano fare acquisti basati sulle loro reali esigenze.
Un buon inizio
Lo spreco alimentare è riconducibile a molte cause, alcune delle quali non facili da identificare. E poiché le perdite non si verificano sempre là dove sono state causate, il problema deve essere affrontato in modo globale, ovvero lungo l’intera catena del valore. Ma le dichiarazioni di intenti sono sufficienti? Non sarebbero meglio apposite leggi? Josef Känzig spiega le due fasi del piano d’azione. Nella prima fase, fino al 2025, l’obiettivo è cercare soluzioni intersettoriali e vedere quali risultati si possono ottenere. La Svizzera non è sola in questo approccio. Esempi di approcci simili in Paesi come la Norvegia o l’Inghilterra dimostrano che la combinazione tra impegno volontario dei vari settori e stretta collaborazione con le organizzazioni governative può rivelarsi ottimale nel perseguire la riduzione dello spreco alimentare. In una seconda fase, dopo il 2025, il Consiglio federale potrà adottare o esaminare ulteriori misure, a seconda che i risultati raggiunti nel frattempo siano più o meno incoraggianti. Anche Claudio Beretta considera il piano d’azione e l’accordo intersettoriale un buon inizio, nei quali saranno costantemente coinvolti altri attori rilevanti. Nel settore della ristorazione, ad esempio, sono necessari anche i ristoranti di medie e piccole dimensioni per ridurre in modo efficiente le perdite di cibo.
Nel frattempo le soluzioni proposte da alcune app innovative potrebbero essere di aiuto, come quella della start-up «Prognolite», che mette a disposizione delle imprese della ristorazione e delle panetterie uno strumento che utilizza l’intelligenza artificiale per fare previsioni sul numero di clienti, consentendo così una pianificazione ottimale del menu. Esistono altri approcci tecnologici relativi alla durata di conservazione, come i rivestimenti di frutta e verdura o i trucchi per lo stoccaggio. Sohm immagina che con i mezzi digitali si possa creare per il cibo qualcosa di simile a un portale di incontri, in cui le eccedenze di produzione vengano «abbinate» alle capacità disponibili di commercianti o riciclatori.
Ritiene che queste innovazioni siano estremamente promettenti, ma aggiunge di non avere ancora visto nessuna soluzione buona per tutte le stagioni. Forse non ce n’è nemmeno bisogno se tutti collaborano e danno il proprio contributo. Per tornare ancora una volta al pane: con gli avanzi si possono fare molte cose in cucina, come sapevano i nostri nonni e come sanno anche giovani chef e ristoratori sempre più creativi.
Tre consigli per evitare lo spreco alimentare

Qui una patata di troppo, là un avanzo di pasta nella pentola: spesso si tratta di piccole porzioni che rimangono e che poi vengono gettate via. Pertanto, o si cucina una porzione doppia e il giorno dopo si riscalda una porzione intera o si fanno porzioni giuste già prima di cucinare. Spesso gli avanzi possono anche essere combinati tra loro, quindi, il giorno prima di fare la prossima grossa spesa, meglio dedicarsi al loro consumo. E se non piace mangiare di nuovo gli stessi avanzi, è consigliabile un approccio più creativo, perché molte cose possono essere facilmente trasformate in un nuovo menu. Conservare gli avanzi di cibo in contenitori trasparenti e sistemarli in modo da non dimenticarli: ogni volta che si aprirà il frigorifero, saranno lì a dirvi: «consumami!».

Le date di scadenza indicano che un prodotto va consumato preferibilmente entro quella data e spesso anche oltre, sono cioè un aiuto per orientarsi. Ci si può anche affidare ai sensi: guardare, annusare, assaggiare, per scoprire se gli alimenti sono ancora commestibili. Sistemare rapidamente i generi alimentari in frigorifero per evitare che si deteriorino o metterli nel congelatore, se ci si accorge di averne comprato in eccesso. La maggior parte può essere congelata senza bisogno di ulteriori accorgimenti.

E acquistare con lungimiranza. Valutando adeguatamente il proprio fabbisogno settimanale e facendo una lista della spesa dettagliata, si acquisterà in modo più consapevole. Prima di fare la spesa, dare sempre un’occhiata al frigorifero per vedere cosa è rimasto. Privilegiare le porzioni piccole o non confezionate e fare attenzione alle promozioni, che spesso invogliano a comprare più del necessario, approfittandone solo se si è sicuri di consumare effettivamente i generi alimentari che si comprano. Ogni volta che è possibile, inoltre, acquistare prodotti di stagione.
Partire già dalla formazione
Sul tema delle perdite alimentari, tutta la società è chiamata in causa. Anche la formazione è un fattore chiave quando si tratta di garantire che misure importanti siano sostenute da tutti. Il Consiglio federale prevede quindi di coinvolgere le scuole dell’obbligo e le scuole universitarie, come pure il settore della formazione professionale e della formazione continua. Il piano d’azione si basa sull’esistente: nella formazione di singole professioni quali cuoco, panettiere o negli studi post-laurea in gestione alberghiera, l’argomento delle perdite alimentari riveste già una grande importanza. L’UFAM sostiene gli organi competenti nell’elaborazione o nella revisione dei materiali didattici per i programmi della formazione professionale di base. Il tema delle perdite alimentari dovrebbe essere incluso anche nei corsi di preparazione e negli esami professionali, così come potrebbe essere trattato in modo più esteso nelle scuole dell’obbligo. La responsabilità principale spetta ai Cantoni, i destinatari sono insegnanti e direttori scolastici. L’obiettivo è tematizzare le perdite alimentari durante le lezioni e, idealmente, fare in modo che tutta la scuola si dedichi all’argomento, ad esempio in relazione ai pasti della pausa pranzo.
Conclusioni
Lungo la filiera dal campo al piatto, in Svizzera vanno persi ogni anno circa 2,8 milioni di tonnellate di cibo, pari a circa 330 chilogrammi per persona all’anno. Allo scopo di dimezzare le perdite alimentari entro il 2030, il Consiglio federale ha adottato un piano d’azione e coinvolto gli attori più importanti dell’intera catena alimentare in un accordo intersettoriale. L’obiettivo è di dimezzare rispetto al 2017 la quantità di perdite alimentari evitabili entro il 2030.
Ulteriori informazioni
Ultima modifica 15.03.2023